Siena di notte
 Lettori senesi sono stati così gentili da segnalare i nostri scritti sul Palio e la loro Città, che meritano, contraccambiandoli dell’attenzione e della gentilezza, che a nostra volta portiamo loro a conoscenza (o rammemoriamo per chi – ma ne dubitiamo, salvo forse qualche “letterato”- già lo conoscesse) questo vecchio scritto (datato 1899) del pubblicista, storiografo, romanziere ecc., Alfredo Oriani (1852 – 1909), di impronta nazionalistica e perciò oggi alquanto dimenticato, che traiamo da un libro che da parecchio tempo sonnecchiava, quasi mai aperto, nella nostra biblioteca, che fu edito a Bologna nell’ormai lontano 1928 dall’editore Licinio Cappelli, col titolo “Alfredo Oriani – Gli Eroi, Gli Eventi, Le Idee”. Pagine scelte, con prefazione di Luigi Federzoni.
Lettori senesi sono stati così gentili da segnalare i nostri scritti sul Palio e la loro Città, che meritano, contraccambiandoli dell’attenzione e della gentilezza, che a nostra volta portiamo loro a conoscenza (o rammemoriamo per chi – ma ne dubitiamo, salvo forse qualche “letterato”- già lo conoscesse) questo vecchio scritto (datato 1899) del pubblicista, storiografo, romanziere ecc., Alfredo Oriani (1852 – 1909), di impronta nazionalistica e perciò oggi alquanto dimenticato, che traiamo da un libro che da parecchio tempo sonnecchiava, quasi mai aperto, nella nostra biblioteca, che fu edito a Bologna nell’ormai lontano 1928 dall’editore Licinio Cappelli, col titolo “Alfredo Oriani – Gli Eroi, Gli Eventi, Le Idee”. Pagine scelte, con prefazione di Luigi Federzoni.
Lo scritto in questione, per il tono verista e allo stesso tempo nostalgico, in cui immagine fotografica, evocazione storica, piacere estetico, solipsismo, si confondono, suscita, rivolgendosi sia all’animo che all’intelletto, tanto delicatezza di sentimenti quanto pregnanza di riflessioni. Pensiamo ad esempio alla “bellezza” che – ci dice l’Autore – in quel tempo, ahinoi perduto, “doveva essere la prima fisionomia delle cose”, e facciamo un raffronto con lo sfascio edilizio, la bruttezza, la spazzatura di ogni tipo, che dal secondo dopoguerra ad oggi hanno cominciato, e in maniera sempre più stringente, vero specchio dei tempi, a circondarci da ogni dove; o al “popolo“ di allora che “costituiva nel Duomo la propria epopea” come quando “osannando“ vi portò “la grande tavola di Duccio”, e a quello di oggi – ma può chiamarsi ancora “popolo” quello che a più riguardi è solo una pappina informe? – tutto squadre di calcio, corse di bolidi di latta e quant’altro c’è di più insignificante, d’effimero, d’impermanente, mentre il resto, quello che per le genti di prima più contava quanto a stabilità e in quanto strumento di unione fra mondo e sovramondo, è per esso il nulla più assoluto; pensiamo a tanti capolavori di allora, di architettura, pittura ecc. che spesso, più erano belli – accenna il nostro A. – più erano anonimi, come a significare che in ogni artefice, pittore, architetto, a riverberare era sempre e soltanto l’idea dell’Unico Artefice, dell’Unico Grande Architetto, e confrontiamoli con le banalità, per non dire sovente le bruttezze o addirittura le schifezze (chi non ricorda la famosa “m…a d’artista”?), che ci vengono quotidianamente ammannite nei più svariati campi come “opere d’arte”, tutte rigorosamente “firmate” col nome e cognome dell’autore perché così vuole il narcisismo moderno.
Questo scritto dell’Oriani pertanto merita (la prosa in cui è confezionato è peraltro splendida, il suo italiano bellissimo) di essere senz’altro, come qui facciamo, riproposto.
 In un punto tuttavia l’Autore deve essere corretto, quando nel finale conclude affermando che “Siena è morta”. No, Siena non è morta. Certamente, non c’è più, è morta, la Repubblica dei Mercanti (ché gli stessi “Nobili”, prima di essere nobilitati furono essi stessi mercanti arricchitisi a mezzo dell’esercizio della mercatura in Europa e nel Levante, donde forse anche la mezzaluna che compare nel blasone di certe famiglie, prova provata che le famose “radici” non sono una sola, come pretenderebbero alcuni, ma plurime), i quali tanto dettero in Arte e Storia all’Italia e all’Umanità, né i loro attuali epigoni (se così li possiamo chiamare) sembrano, in recenti, note, vicende di cui tutti hanno parlato e parlano, avere dato gran prova di sé (ed anche in questo, sia detto en passant, va verosimilmente ravvisato l’effetto di quella moderna “confusione delle Caste” per cui il Potere e i poteri vengono affidati a chi per la costituzione della sua natura non è in grado di esercitarli nel modo in cui dovrebbero essere esercitati). Se, tuttavia, lasciamo “Via di Città”, quella più affollata di turisti, se ci inoltriamo solinghi nella Via del Casato, la risaliamo su, su, fino a Via delle Murella, dove più rari sono i passanti, fino a giungere nella parte cacuminale della Città, dove forse sorse il suo nucleo originario, fra gli antichi e meno antichi palagi, fra le case del Popolo, che i vasi di gerani e di basilico sul davanzale delle finestre ingentiliscono, nel silenzio dei luoghi, lo Spirito, l’Essenza della Città si sentono alitare ancora, di guisa che viene fatto di assentire dal profondo a quell’espressione dell’indimenticato Silvio Gigli, ricordata dai telecronisti del Palio di qualche giorno fa: “Sempre trionfa Siena Immortale”.
In un punto tuttavia l’Autore deve essere corretto, quando nel finale conclude affermando che “Siena è morta”. No, Siena non è morta. Certamente, non c’è più, è morta, la Repubblica dei Mercanti (ché gli stessi “Nobili”, prima di essere nobilitati furono essi stessi mercanti arricchitisi a mezzo dell’esercizio della mercatura in Europa e nel Levante, donde forse anche la mezzaluna che compare nel blasone di certe famiglie, prova provata che le famose “radici” non sono una sola, come pretenderebbero alcuni, ma plurime), i quali tanto dettero in Arte e Storia all’Italia e all’Umanità, né i loro attuali epigoni (se così li possiamo chiamare) sembrano, in recenti, note, vicende di cui tutti hanno parlato e parlano, avere dato gran prova di sé (ed anche in questo, sia detto en passant, va verosimilmente ravvisato l’effetto di quella moderna “confusione delle Caste” per cui il Potere e i poteri vengono affidati a chi per la costituzione della sua natura non è in grado di esercitarli nel modo in cui dovrebbero essere esercitati). Se, tuttavia, lasciamo “Via di Città”, quella più affollata di turisti, se ci inoltriamo solinghi nella Via del Casato, la risaliamo su, su, fino a Via delle Murella, dove più rari sono i passanti, fino a giungere nella parte cacuminale della Città, dove forse sorse il suo nucleo originario, fra gli antichi e meno antichi palagi, fra le case del Popolo, che i vasi di gerani e di basilico sul davanzale delle finestre ingentiliscono, nel silenzio dei luoghi, lo Spirito, l’Essenza della Città si sentono alitare ancora, di guisa che viene fatto di assentire dal profondo a quell’espressione dell’indimenticato Silvio Gigli, ricordata dai telecronisti del Palio di qualche giorno fa: “Sempre trionfa Siena Immortale”.
Bennato Bennati
***
Siena di Notte
Mezzanotte era suonata da un pezzo.
Per le vie strette e sinuose i fanali rossi rompevano duramente le ombre della notte, in alto così serena e stellata. Non passava più alcuno, ma quel sogno mi saliva sempre nell’anima come uno spettacolo, che mi si dilatasse lentamente dinanzi agli occhi.
Era Siena antica, colle vie senza lampioni, silenziosa sotto l’orgoglio dei palagi ancora frementi del suo tumulto quotidiano fra le guerre e le perfidie della grande epoca ghibellina. I suoi centomila partigiani, adesso ridotti ad un quarto ed assopiti nell’immemore placidezza dell’ozio provinciale, vibravano allora di superbia regale ad ogni minaccia contro la loro repubblica fieramente campata sulla tricuspide dei propri colli, dalla quale l’esile torre del Mangia saliva come l’asta del gonfalone. La vita era una guerra; sopra tutti i poggi vegliava un castello, in ogni palagio della città si annidava una fazione, gli ospiti erano fuoriusciti, gli alleati sempre infidi, le conquiste più incerte dopo la vittoria che prima della battaglia. La città, repubblica o signoria, formava contro il mondo una patria violata spesso come una vergine troppo ritrosa; battuta come una moglie infedele, adorata come una madre, della quale si è gelosi senza pietà ed alteri sino all’insulto.
 L’odio di Siena era Firenze; questa, sdraiata sulla doppia sponda dell’Arno, quella seduta fra i monti, appena coll’Arbia al piede, un torrentello che il sangue di ogni scaramuccia bastava a colorare in rosso; Siena non poteva vivere, diventare ricca perché le mancavano le pianure e il fiume e il mare, ma seppe essere forte e volle diventare bella come la rivale, cui doveva soggiacere lentamente. Oggi ancora non è mutata. Di notte le sue strade, le sue piazze, i suoi palagi, le sue chiese riappaiono nel sogno antico: il silenzio diviene trepido fra le ombre, si guarda incerti fra lo sbocco delle viuzze che discendono tortuosamente come sentieri, si rimane perplessi dinanzi ai suoi androni aperti nei fianchi neri di una casa, della quale le finestre hanno un’eleganza di cornice biancheggiante d’intarsi: non una carrozza rotola sordamente sui lastroni, non una bottega fiammeggia ancora dalle proprie vetrine. Dentro quei palazzi, che paiono tagliati da un orafo nel vivo di una roccia, debbono vigilare ancora i fantasmi di un tempo perché la nostra vita non poté imprimersi sulle loro pietre; i loro portoni custodiscono ancora qualche segreto, dietro le vetrate delle finestre sulle quali tremolano i sorrisi delle stelle, si mormorano forse parole perigliose; qualche dama insonne spia, qualche signore aspetta cupamente, ascoltando nel pensiero, gli ordini implacabili della propria congiura. Il tumulto di un’ora può essere sufficiente al trionfo: poca mano di armati asserragliando le strade, basterà a mutare la sua reggia di privato in una fortezza; le prime bande, che sbocchino nel Campo, a cacciare di Palazzo i Priori.
L’odio di Siena era Firenze; questa, sdraiata sulla doppia sponda dell’Arno, quella seduta fra i monti, appena coll’Arbia al piede, un torrentello che il sangue di ogni scaramuccia bastava a colorare in rosso; Siena non poteva vivere, diventare ricca perché le mancavano le pianure e il fiume e il mare, ma seppe essere forte e volle diventare bella come la rivale, cui doveva soggiacere lentamente. Oggi ancora non è mutata. Di notte le sue strade, le sue piazze, i suoi palagi, le sue chiese riappaiono nel sogno antico: il silenzio diviene trepido fra le ombre, si guarda incerti fra lo sbocco delle viuzze che discendono tortuosamente come sentieri, si rimane perplessi dinanzi ai suoi androni aperti nei fianchi neri di una casa, della quale le finestre hanno un’eleganza di cornice biancheggiante d’intarsi: non una carrozza rotola sordamente sui lastroni, non una bottega fiammeggia ancora dalle proprie vetrine. Dentro quei palazzi, che paiono tagliati da un orafo nel vivo di una roccia, debbono vigilare ancora i fantasmi di un tempo perché la nostra vita non poté imprimersi sulle loro pietre; i loro portoni custodiscono ancora qualche segreto, dietro le vetrate delle finestre sulle quali tremolano i sorrisi delle stelle, si mormorano forse parole perigliose; qualche dama insonne spia, qualche signore aspetta cupamente, ascoltando nel pensiero, gli ordini implacabili della propria congiura. Il tumulto di un’ora può essere sufficiente al trionfo: poca mano di armati asserragliando le strade, basterà a mutare la sua reggia di privato in una fortezza; le prime bande, che sbocchino nel Campo, a cacciare di Palazzo i Priori.
Il Campo, che non poté assumere nemmeno oggi il nome di piazza, rimaneva sempre aperto ad ogni impeto, e fioriva di sangue tutti gli anni. La vezzosa originalità del suo disegno che lo faceva supporre creato per l’incanto di una festa, era ancora una contraddizione di quell’epoca che metteva una bellezza dappertutto, anche dove il dolore era più disperato e la realtà più sconcia.
È una piazza e pare una conchiglia: ai piedi della torre del Mangia, l’automa che vi batterà le ore, una piccola cappella annerita dal tempo vi fu trasportata forse dagli angeli, così lieve è la sua grazia, e vi rimase, miracolo maggiore, a testimone di altro miracolo; palazzi merlati guardavano superbamente al Palazzo pubblico anche più altero, e in alto, sull’orlo della conchiglia, canta il coro delle fontanelle dentro il recinto della Gaia Fonte.
A quell’ora, sul Campo l’ombra oscillava mollemente, nessuna scolta guardava i cancelli neri del Palazzo, nessuna voce rompeva il silenzio da lungi o da presso. Come la Piazza di Venezia, il Campo era stato spesso alla repubblica parlamento e sala di festa nei giorni gloriosi, quando ambasciatori venivano a chiedere alleanza o i gonfaloni tornavano insanguinati dalla vittoria; nel suo mezzo Provenzano Salvani, il grande capitano senese che vinse con Farinata degli Uberti, la giornata di Monteaperti, distese magnanimo il proprio mantello e chiese ai cittadini come premio l’elemosina di 10.000 fiorini d’oro per il riscatto del suo amico Vigna, prigioniero del Re Carlo I° di Puglia. E l‘altero si condusse “a tremar per ogni vena” e nello sforzo di questa umiltà che noi non sappiamo nemmeno più intendere. Il nostro spirito si turba indarno dinanzi alla memoria di quel tempo, nel quale la fede fiammeggiava fra la passione, e la bellezza era la prima necessità di ogni linguaggio
Dal ricamato mantello del cavaliere alla clamide di marmo gettata su tutti i palazzi e le chiese, la bellezza doveva essere la prima fisionomia delle cose e delle persone: i mercanti si ergevano logge decorate come un tempio, il popolo si costituiva nel Duomo la propria epopea.
Come i poeti dell’epopea, gli architetti vi rimanevano spesso ignoti, mentre l’unità primitiva del loro disegno si frangeva a mano a mano negli episodi devoti delle cappelle, dentro la lirica improvvisata dei miracoli. Le città e le castella suddite contribuivano con uguale passione al capolavoro, che significava la loro unione, e nel quale ogni più ritrosa originalità dell’ingegno veniva a sottomettersi senz’altra mercede che la comunione della bellezza creata, e la superbia di avere sconfitto nella grande opera qualche altra repubblica. Così il dominio di Siena poté vincere quello di Firenze e un artista incomparabile, l’ultimo dei grandi forse, vi distese sul pavimento il proprio genio, sprezzante che i piedi delle turbe adoratrici potessero poi logorare i quadri incisi dal suo stilo. Perché tutto doveva essere divino in quel tempio al quale il popolo portò osannando la grande tavola di Duccio, mentre le campane suonavano a distesa, e un singhiozzo d’orgoglio scuoteva le anime inebriate dal trionfo della fede. Oggi il tempio non è più che bello: la nostra incredulità vi cerca curiosamente i prodigi dell’ingegno come dentro un museo, senza più sentirne l’armonia e penetrarne lo spirito: la bellezza ci distrae invece di raccogliere ed elevare i nostri sentimenti, storia e critica separano e sezionano in noi le visioni dei grandi artisti morti, mentre una specie di paura colpisce la nostra dotta ignoranza dinanzi al mistero della loro creazione. Noi non sentiamo più Dio, la nostra democrazia non ha più quell’unità morale, donde uscivano i grandi simboli delle grandi opere: coloro che, fra noi pregano ancora, hanno bisogno di tagliarsi nell’immenso Duomo una cappella e non sanno ornarla che di oro; la ricchezza è la nostra sola offerta, dacché la volgare anima moderna non domanda nemmeno più alle immagini sante di essere belle.
Usciamo dunque dal tempio noi che non potremmo trovarvi Dio, benché forse sia ancora avvolto nelle ombre e parli nelle preghiere, che le cose belle innalzano verso di lui: già l’importanza dell’uomo vi ha scemato il rispetto divino coprendo di un tavolato il sublime pavimento del Beccafumi. Povero, grande artista che non lo avresti mai supposto, quando, maggior poeta dei tuoi rivali e più grande credente fra i fedeli, gettavi sotto i piedi della moltitudine le immagini del tuo pensiero colla semplicità di un bambino, che spoglia i vasi della mamma per sfogliarne i fiori sotto l’altarino alzato nell’andito oscuro della casa! Ti ammiriamo troppo per comprenderti abbastanza, oggi che si mettono i caloriferi nelle chiese perché le orazioni non raggelino sulle labbra dipinte delle dame o la voce del predicatore non si appanni nella predica indarno verbosa.
 Ma la fede allora brillava di uguale splendore sui culmini del genio e nel cuore della moltitudine, che si riconosceva negli eroi e nei santi, nel canto dei poeti e nelle figure dei pittori. Al palagio del signore, così spesso teatro delle più cupe tragedie, tutta la città aveva del pari contribuito, perché anche quello doveva esprimere la sua gloria e durare forse più di essa. Ecco come noi moderni non abbiamo più che case composte di appartamenti l’uno sull’altro coll’unica legge dell’economia, senza miglior lusso che di un arredo personale. Nessuna nobiltà può venire a noi dalla abitazione o dai mobili che la riempiono: il pensiero degli avi non ci guarda più dalle pareti, la casa non è più come una volta, più antica e maggiore di noi. Siamo nomadi anche nelle città, la nostra immensa ricchezza ignora l’orgoglio della durata e non domanda più né al tempo né all’arte la consacrazione. La Banca d’Italia e il Monte dei Paschi occupano ora a Siena due palazzi di un pregio assai maggiore che non tutti i milioni rotolanti per le loro scale: il governo ha messo non so che cosa nel Palazzo Piccolomini, una reggia nera, tetramente muta, anche di giorno, quando tutte le finestre ne sono aperte. Dal suo portone uscì Ottavio Piccolomini, il nemico di Wallenstein, per precipitare dentro una lubrica tragedia italiana il massiccio eroe tedesco. Ho cercato sotto il palazzo Tolomei la finestra alla quale deve avere sospirato la Pia, e sotto alla quale anche Dante si sarà arrestato forse di notte come me, sognando di quella mite precipitata da un’altra finestra di un castello maremmano; mi sono fermato a lungo sulla Piazza alta del Duomo a guardare quel frammento dirupo, che doveva raddoppiarne la mole, e anche adesso è più bello di tutto il tempio. Non si vede che un’immensa finestra incorniciata di marmo bianco, sostenuta da colonnine, trapunta di ricami, così lieve che il vento avrebbe già dovuto portarla seco, e che aperta nel cielo, vi segna al pensiero una via.
Ma la fede allora brillava di uguale splendore sui culmini del genio e nel cuore della moltitudine, che si riconosceva negli eroi e nei santi, nel canto dei poeti e nelle figure dei pittori. Al palagio del signore, così spesso teatro delle più cupe tragedie, tutta la città aveva del pari contribuito, perché anche quello doveva esprimere la sua gloria e durare forse più di essa. Ecco come noi moderni non abbiamo più che case composte di appartamenti l’uno sull’altro coll’unica legge dell’economia, senza miglior lusso che di un arredo personale. Nessuna nobiltà può venire a noi dalla abitazione o dai mobili che la riempiono: il pensiero degli avi non ci guarda più dalle pareti, la casa non è più come una volta, più antica e maggiore di noi. Siamo nomadi anche nelle città, la nostra immensa ricchezza ignora l’orgoglio della durata e non domanda più né al tempo né all’arte la consacrazione. La Banca d’Italia e il Monte dei Paschi occupano ora a Siena due palazzi di un pregio assai maggiore che non tutti i milioni rotolanti per le loro scale: il governo ha messo non so che cosa nel Palazzo Piccolomini, una reggia nera, tetramente muta, anche di giorno, quando tutte le finestre ne sono aperte. Dal suo portone uscì Ottavio Piccolomini, il nemico di Wallenstein, per precipitare dentro una lubrica tragedia italiana il massiccio eroe tedesco. Ho cercato sotto il palazzo Tolomei la finestra alla quale deve avere sospirato la Pia, e sotto alla quale anche Dante si sarà arrestato forse di notte come me, sognando di quella mite precipitata da un’altra finestra di un castello maremmano; mi sono fermato a lungo sulla Piazza alta del Duomo a guardare quel frammento dirupo, che doveva raddoppiarne la mole, e anche adesso è più bello di tutto il tempio. Non si vede che un’immensa finestra incorniciata di marmo bianco, sostenuta da colonnine, trapunta di ricami, così lieve che il vento avrebbe già dovuto portarla seco, e che aperta nel cielo, vi segna al pensiero una via.
Tale rimane perché gli architetti d’allora non la giudicarono abbastanza ben costruita: incantevole errore, se qualche invidioso non lo inventò, che mi ricorda l’inno del Foscolo alle Grazie, incompiuto anch’esso, e appunto per questo più divino fra l’oscurità delle sue lacune, come tutte le rivelazioni.
Un orologio suona le tre del mattino.
Anche ieri notte, malgrado i cento chilometri battuti di così buon trotto, sono rimasto lungamente alla finestra, guardando giù nel giardino e nella strada che si inabissa e poi sale verso la spianata di San Domenico, una chiosa cupamente religiosa, di una sola navata, colle pareti nude e i finestroni alti e stretti come feritoie. La notte era quieta come questa, un profumo di rose saliva dal giardino col canto di un usignolo.
Una strofa giapponese dice: “l’usignolo ha pregato tutta la notte sotto la rosa, ma essa non ha potuto rattenere le proprie foglie, che sono cadute ad una ad una”.
Adesso invece le fontanelle della Gaia Fonte dietro e dintorno a me cantano sui bacinetti: sono lungo disteso sopra un gradino bianco, colla testa sul marmo guardando in alto; nessuno verrà a cercarmi, la piazza è deserta come il colle di Monteaperti.
Dove dormono dunque i poveri in questa canicola, poiché a nessuno di essi è venuta a mia idea?
 Eppure Santa Caterina, la sola divinità di Siena, dai quindici ai diciott’anni, dormi anch’essa sulla pietra, col cilicio sulle reni e una corona di spine sotto il cappuccio. Il sangue di veggente le bruciava forse troppo le vene per consentirle il letto di ogni donna, o come tutte le grandi anime, aveva anch’essa sete di dolore e martirizzava la propria giovinezza per renderla padrona della vita. Adesso hanno fatto un tempio della sua casa, ma il più grande miracolo della santa mi è apparso appunto nell’averlo permesso quant’oro, quanti fregi per la sua anima che si mostrò nuda nella tirannia del proprio genio! Quante fanciulaggini dipinte per lei che dominò virilmente il proprio tempo, e ammoniva Alberico da Barbiano, richiamava Gregorio XI da Avignone, dettava norme per gli stati colla più violenta sicurezza dei più temprati avventurieri, in quella fosca rivoluzione militare che preparava l’avvento delle Signorie!
Eppure Santa Caterina, la sola divinità di Siena, dai quindici ai diciott’anni, dormi anch’essa sulla pietra, col cilicio sulle reni e una corona di spine sotto il cappuccio. Il sangue di veggente le bruciava forse troppo le vene per consentirle il letto di ogni donna, o come tutte le grandi anime, aveva anch’essa sete di dolore e martirizzava la propria giovinezza per renderla padrona della vita. Adesso hanno fatto un tempio della sua casa, ma il più grande miracolo della santa mi è apparso appunto nell’averlo permesso quant’oro, quanti fregi per la sua anima che si mostrò nuda nella tirannia del proprio genio! Quante fanciulaggini dipinte per lei che dominò virilmente il proprio tempo, e ammoniva Alberico da Barbiano, richiamava Gregorio XI da Avignone, dettava norme per gli stati colla più violenta sicurezza dei più temprati avventurieri, in quella fosca rivoluzione militare che preparava l’avvento delle Signorie!
Due terzine di Dante sono bastate nondimeno a farle in tutti i cuori una rivale della Pia, gentildonna forse insignificante, sacrificata ad una volgare avarizia di altre nozze, ma indimenticabile ora dopo quel suo patetico appello alla memoria del mondo.
Siena dorme.
Il suo letargo dura dal giorno che Cosimo dei Medici ottenne da Filippo II di Spagna il titolo di duca, colla facoltà di scoronare tutte le città della Toscana, per fondere coi frammenti delle loro, la propria corona ducale, ma la grande vita delle Repubbliche e delle Signorie aveva cessato da tempo. Firenze sopravvisse in un orgoglio di capitale, Siena si addormentò sul proprio Campo, fra l’ombra del palazzo Pubblico e quella del Duomo per non svegliarsi mai più. Adesso è capoluogo di una provincia più piccola del suo antico stato, e non s’accoglie entro il Campo che una volta all’anno per applaudire la corsa delle Contrade. La loggia dei suoi mercanti è divenuta un club di nobili, la sua università non è più che un frammento, i suoi palazzi appartengono a gente senza nome, il suo popolo non basta più a riempire nemmeno le sue chiese.
Però l’epidemia industriale ha risparmiato la dormiente: spegnete i fanali e ritorneranno i sogni di una volta, perché le ombre ne sono piene. Le sue regge, le sue vie sono intatte, nel giorno le botteghe ne viziano lo stile e ne deturpano la fisionomia, ma di notte l’oscurità e il silenzio le ritornano quali erano nella grande epoca della gloria e della bellezza. Le donne non avranno che a mostrarsi dentro una delle mille finestre binate per parere più belle; agli uomini basterà un mantello e un berretto per sembrare cavalieri, mentre per le stradicciuole ricominceranno bisbigli di congiure e l’antica tragedia proseguirà nuovamente nell’incanto della notte.
Un poeta sdraiato al pari di me su questo gradino della Gaia Fonte potrebbe compiere il miracolo mettendo in questo sogno la vita sonnambula dell’arte, nella quale i fantasmi hanno talvolta la virtù dei viventi.
Dov’è dunque il poeta ?
Le fontanelle ripetono ancora il coro della prima ora, quando Iacopo della Quercia le scoprì fra gli applausi di tutto il popolo, ma le loro dolci e monotone sillabe non dicono nulla al mio orecchio di vagabondo insonne: ho la testa vuota come il Campo, sul quale l’ombra oscilla sempre così mollemente, la torre biancheggia alla cima quasi coperta da una cotta, il portico del Palazzo Pubblico è nero e il Palazzo vuoto.
Siena è morta.

 Articolo Precedente
Articolo Precedente Articolo Successivo
Articolo Successivo L’inconscio collettivo tra gender e unioni civili
L’inconscio collettivo tra gender e unioni civili  Il tesoro in bocca. Angelo Maria Ripellino, “Praga magica” e la sua lingua
Il tesoro in bocca. Angelo Maria Ripellino, “Praga magica” e la sua lingua  “Israelizzazione” delle società europee e compattamento del “fronte occidentale”
“Israelizzazione” delle società europee e compattamento del “fronte occidentale”  Astruserie del “pensiero cristiano”: l’Islam non conosce la Misericordia e il Perdono!
Astruserie del “pensiero cristiano”: l’Islam non conosce la Misericordia e il Perdono! 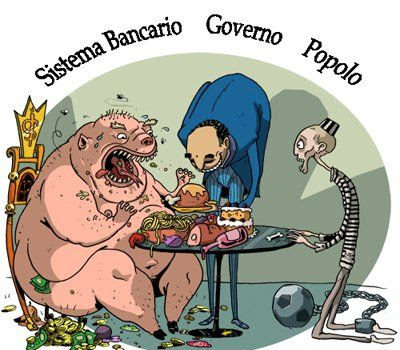 Espedienti preelettorali di questo regime: lo scontro tra “fascisti” e “comunisti”
Espedienti preelettorali di questo regime: lo scontro tra “fascisti” e “comunisti”  Falsità ed ipocrisia occidentali dell’orrore verso l’ISIS. Cap. 3: l’iconoclastia e la distruzione dei luoghi sacri
Falsità ed ipocrisia occidentali dell’orrore verso l’ISIS. Cap. 3: l’iconoclastia e la distruzione dei luoghi sacri  La politica araba ed islamica italiana che fu…
La politica araba ed islamica italiana che fu… 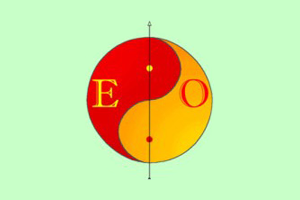 L’oggetto misterioso. L’immagine dell’Islam nell’Italia tra le due guerre mondiali
L’oggetto misterioso. L’immagine dell’Islam nell’Italia tra le due guerre mondiali