Ma un giorno, per caso…
di Francesco Lamendola
 Quanto peso è giusto che concediamo al nostro passato; fino a che punto è accettabile che permettiamo alle nostre antiche ferite di tormentare il nostro presente?
Quanto peso è giusto che concediamo al nostro passato; fino a che punto è accettabile che permettiamo alle nostre antiche ferite di tormentare il nostro presente?
Certo, non esistono dei tempi uguali per tutti, a questo riguardo; quanto più si è sensibili, quanto più si è sentimentali – sia detto nel miglior senso del termine -, tanto più si ha bisogno di tempo per dimenticare, o, quanto meno, per far sì che il dolore diventi sopportabile, abbastanza da permetterci di convivere con la sua sgradita compagnia. Possono volerci delle settimane, dei mesi, degli anni… e anche di più.
Ma un giorno, per caso, quando meno ce lo aspettiamo, ecco che il caso – o, almeno, di solito noi pensiamo che sia il caso – ci fa incontrare proprio colui, o colei, che non avremmo voluto incontrare; o piuttosto, che avremmo voluto, eccome, a condizione, però, che le vicende della nostra vita fossero andate diversamente; meglio ancora: che avremmo voluto, e insieme che non avremmo voluto, incontrare, appunto perché ci eravamo sforzati in ogni modo di dimenticarlo (o di dimenticarla), e vi avevamo pensato anche troppo: infatti avevamo permesso che settimane e mesi ed anni si sovrapponessero gli uni agli altri, senza avere il coraggio di sciogliere quel nodo, in un modo o nell’altro: in quello di riallacciare quel rapporto, oppure di metterci sopra una pietra tombale, una volta per tutte.
Ed ecco che anche lui, o lei, ci ha visti; per un istante, i nostri occhi s’incrociano, i nostri sguardi s’interrogano; tutto un caleidoscopio di sentimenti, che credevamo sopiti, se non addirittura spenti, si ridesta nell’anima e traspare dal volto: il cuore batte violentemente, come afferrato da una forza più grande di lui, indomabile, immensa. Ci sentiamo quasi perduti, temiamo che il nostro segreto venga scoperto, che le nostre difese, così faticosamente erette sulle macerie di sentimenti offesi, calpestati, umiliati, vengano di nuovo spazzate via, come se quel che accadde fosse stato ieri. Il tempo sembra cancellato, annullato, sospeso.
Ma non è che un istante. Lui (o lei) gira la testa dall’altra parte, forse con sufficiente scioltezza da far sembrare quel gesto del tutto naturale; in teoria, è perfino possibile che non ci abbia riconosciuti, che sia stata solo una nostra impressione. Tuttavia, noi sappiamo perfettamente, con assoluta certezza, che non è affatto così; che ci ha visti, che ha realizzato la situazione, che l’ha soppesata fulmineamente e che ha preso la sua decisione: fare finta di nulla, voltarsi e proseguire il cammino, come se non fosse successo niente.
O forse siamo stati noi a fare così: forse siamo stati noi che, in quelle frazioni di secondo che ci sono piombate addosso con la forza devastante di un ciclone, abbiamo deciso, con la velocità d’un lampo, di voltare la testa dall’altra parte e fare finta di nulla; magari con un sorriso di scherno, oppure con una smorfia di disappunto, oppure ancora con una espressione turbata, che lascia trasparire, nostro malgrado, tutta l’agitazione, ma no, tutto il terrore, il terrore folle, il senso spaventoso di fragilità e d’essere totalmente inermi, che ci ha invasi e che, in un attimo, ha annientato le nostre sicurezze, il nostro apparente autocontrollo. Non vogliamo che lui (o lei) veda quanto quell’incontro ci ha sconvolti; non vogliamo concedere una tale soddisfazione a chi è stato causa d’infinite sofferenze; non vogliamo, soprattutto, ch’egli (o ella) possa trarne motivo d’orgoglio, possa dedurne che noi siamo ancora allo stesso punto di allora, vulnerabili e inermi, del tutto alla mercé di un ricordo implacabile, spietato.
Sono attimi irripetibili, eccezionali, nei quali la nostra anima si rivela a noi stessi con una potenza, con una irruenza, che non avremmo neppure sospettato; in cui un paziente, doloroso lavorio di medicazione affettiva, che abbiamo condotto su noi stessi, rischia d’infrangersi, di schiantarsi miseramente, lasciandoci, di nuovo, nudi ed esposti, come un lacero mendicante che si trovi un’altra volta nel gelo e nel vento della notte invernale, da cui aveva trovato rifugio; in cui possiamo misurare, con perfetta e inappellabile verità, se e quanta strada abbiamo fatto da allora: se siamo rimasti come eravamo, se invece siamo diventati altri, e se abbiamo conquistato la forza di guardarci indietro e di riconoscere quello che è stato, quella esperienza che ci ha segnato in maniera indelebile, come un ferro rovente sulla carne viva.
Ci piace riportare una pagina che ben descrive un tale stato d’animo: ne è autore uno scrittore oggi quasi dimenticato, il milanese – poi naturalizzato francese – Luigi Gualdo (1844-98), che fu una specie di ponte fra Scapigliatura e Decadentismo; e il romanzo da cui è tratta s’intitola «Decadenza» (cap. 11; Milano, Bietti, 1967, pp. 138-9):
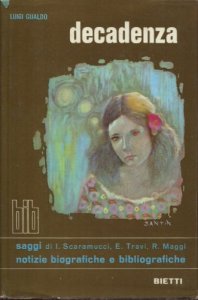 «Ma un giorno tornando dal “Bois” – in quell’ora crepuscolare in cui tutto il lungo viale solcato da mille carrozze d’ogni specie, sembra lievemente avvolto in un pulviscolo dorato che aggiunge una speciale magia al perenne e sempre rinnovato spettacolo, mentr’egli guardava, con avida curiosità, i visi tanto diversi e caratteristici che gli passavano vicino, ad un tratto Silvia in una modesta ma elegante “vittoria” a un cavallo. La vide d’improvviso, benissimo; sentì d’essere visto e subito, fingendo di no, essa aveva voltato la testa dall’altra parte. Il movimento era stato benissimo eseguito, e certo egli poteva dubitare d’essere stato riconosciuto; ma non dubitò. Sentiva ch’ella aveva fatto apposta. Fu un attimo, ma in cui le più varie sensazioni s’avvicendarono vertiginosamente in lui. Ne rimase scosso, e l’amico che lo accompagnava s’accorse di qualche cosa. Si voltò; seguì lungamente con lo sguardo la carrozza che si allontanava; la donna non si volse. La splendida fascia di luce purpurea che irradiava in quell’istante di traverso la superba mole dell’Arco di Trionfo, gli parve sinistra. La scena gli sembrò subitamente mutata, quella scena così caldamente allegra, così animata, divenne triste. Una grande ironia gli pareva incombere su tutto.
«Ma un giorno tornando dal “Bois” – in quell’ora crepuscolare in cui tutto il lungo viale solcato da mille carrozze d’ogni specie, sembra lievemente avvolto in un pulviscolo dorato che aggiunge una speciale magia al perenne e sempre rinnovato spettacolo, mentr’egli guardava, con avida curiosità, i visi tanto diversi e caratteristici che gli passavano vicino, ad un tratto Silvia in una modesta ma elegante “vittoria” a un cavallo. La vide d’improvviso, benissimo; sentì d’essere visto e subito, fingendo di no, essa aveva voltato la testa dall’altra parte. Il movimento era stato benissimo eseguito, e certo egli poteva dubitare d’essere stato riconosciuto; ma non dubitò. Sentiva ch’ella aveva fatto apposta. Fu un attimo, ma in cui le più varie sensazioni s’avvicendarono vertiginosamente in lui. Ne rimase scosso, e l’amico che lo accompagnava s’accorse di qualche cosa. Si voltò; seguì lungamente con lo sguardo la carrozza che si allontanava; la donna non si volse. La splendida fascia di luce purpurea che irradiava in quell’istante di traverso la superba mole dell’Arco di Trionfo, gli parve sinistra. La scena gli sembrò subitamente mutata, quella scena così caldamente allegra, così animata, divenne triste. Una grande ironia gli pareva incombere su tutto.
Aveva avuto come una fitta al cuore; poi in tutto l’essere suo una grande amarezza. La luce subitamente si affievolì; le tinte si fecero fredde; l’aria divenne frizzante.
E non parlò più mentre il loro “fiacre” correva rapidamente, scendendo. Sentiva un disappunto che gli pareva di non aver mai provato. Tentò invano di dissimulare; il suo compagno, benché poco perspicace, si accorse di un subito cambiamento avvenuto in lui, senza però che ne avesse scoperto la causa. Paolo prese un pretesto per lasciarlo, pregandolo di scusarlo presso i compagni coi quali avevano tutti insieme un appuntamento per andare a pranzo. Sentiva un prepotente bisogno d’esser solo.
Assai tardi, quella sera, dopo un lungo e triste vagabondare senza scopo per le vie della grande città, a caso, quasi perduto talvolta, passando dall’allegro e monotono frastuono delle grandi arterie al silenzio delle strade laterali deserte, alla penombra delle piazze isolate, rinfrescate da qualche albero, si trovò, quasi inconsciamente, in un viale abbastanza solitario parallelo ai Campi Elisi, verso la metà, vicino allo stesso posto dove qualche ora prima era stato tanto turbato. La emozione d’allora lo riafferrò; i tumultuosi pensieri aggirantisi intorno ad uno solo – calmati un poco e dispersi per varie vie nella distrazione di quella passeggiata vacua – ora ritornarono di colpo, violenti, incalzanti…».
Ecco: qui Luigi Gualdo ha saputo descrivere assai bene, in poche righe appena, l’effetto sconvolgente di uno di quegli incontri “fatali”, o, per dir meglio, di uno di quei “re-incontri”: quando è come se il passato ci venisse incontro, con stupefacente indifferenza, come quasi che una forza meccanica, di molto superiore all’umana, si divertisse a giocare distrattamente con i nostri sentimenti più cari, e ci sbattesse in viso, con la più grande naturalezza di questo mondo, ciò che invano avevamo cercato di scordare: ciò che aveva torturato i nostri pensieri e la nostra stessa anima, ciascuno dei nostri giorni e delle nostre notti.
E quel gesto della donna, di voltare la testa dall’altra parte; quella decisione presa nel tempo di un battito d’ali; quella sicurezza stupefacente, tale da nascondere perfettamente ogni traccia di turbamento: eppure è chiaro che un turbamento v’è stato; altrimenti, perché fingere di non aver visto e riconosciuto l’uomo? Perché non salutarlo con semplicità, accennando col capo?
 La capacità di padroneggiarsi, di nascondere i segni evidenti del turbamento, non equivale affatto a una vero equilibrio interiore: ne è soltanto la maschera; forse dettata dalla fierezza, dall’orgoglio; o forse dalla paura di apparire debole, di lasciar vedere come l’antico sentimento sia ancora vivo e il tempo trascorso non sia riuscito a cancellare quello che è stato. Anzi, proprio quella prontezza, proprio quel rapido movimento per distogliere lo sguardo, però senza averne l’aria, sono la prova evidente che nulla è stato dimenticato, nulla è stato inghiottito dall’oblio.
La capacità di padroneggiarsi, di nascondere i segni evidenti del turbamento, non equivale affatto a una vero equilibrio interiore: ne è soltanto la maschera; forse dettata dalla fierezza, dall’orgoglio; o forse dalla paura di apparire debole, di lasciar vedere come l’antico sentimento sia ancora vivo e il tempo trascorso non sia riuscito a cancellare quello che è stato. Anzi, proprio quella prontezza, proprio quel rapido movimento per distogliere lo sguardo, però senza averne l’aria, sono la prova evidente che nulla è stato dimenticato, nulla è stato inghiottito dall’oblio.
È quasi spaventosa questa forza del passato, questa indomabilità del passato, che non vuole uscire dalla nostra vita e che grava con il peso di un macigno sopra il nostro presente, impedendoci di andare oltre, di guardare a ciò che ci attende, invece di voltare lo sguardo all’indietro, come se fossimo ipnotizzati da un perfido incantesimo, da un istinto distruttivo, che producono bensì nell’animo un malsano compiacimento, non tale da porgere alcun vero sollievo, non più di chi si gratti incessantemente la stessa piaga sanguinante.
Eppure, anche queste situazioni, per quanto imbarazzanti o dolorose, proprio perché ci mettono in crisi, proprio perché ci mettono a nudo, mostrandoci quanto fragili siano le nostre difese e quanto precario l’equilibrio che credevamo di avere raggiunto, dovrebbero essere accolte con gratitudine, come autentici doni del cielo, mandati a noi affinché possiamo misurare il cammino percorso, comprenderci meglio, riconoscere con maggiore chiarezza e verità la natura dei nostri sentimenti e quel che in essi era solo vanità, orgoglio ferito, sterile rimpianto, e quel che hanno ancora di vivo e di vitale, e che cosa possano ancora dare al nostro sviluppo e alla nostra maturazione. In breve, sono occasioni per fare un bell’esame di coscienza e per capire un po’ meglio chi eravamo, chi siamo attualmente, che cosa vogliamo diventare.
Vi sono poche cose più tristi del voler rimanere aggrappati al proprio passato, e poche cose più biasimevoli del fare finta di aver superato ciò che, invece, non abbiamo mai digerito, perché non abbiamo saputo fare i conti con noi stessi, non siamo stati capaci di domandarci con lealtà quello che volevamo, né interrogarci con franchezza sulle ragioni per cui siamo rimasti delusi e ci siamo sentiti feriti. In linea di massima, si sente ferito chi ritiene di essere stato usato, ingannato, manipolato; e si sente in colpa chi ritiene d’avere fatto ciò a qualcun altro. Questo, beninteso, se si possiede almeno quel minimo di onestà per guardare le cose come stanno, invece di raccontarsele a modo proprio, inventandosi cose che non esistono, allo scopo di giustificare se stessi e di rigettare ogni eventuale colpa, ogni responsabilità sopra gli altri.
 In fondo, e una parte di noi lo sa molto bene, tutte le nostre sofferenze, tutti i nostri errori e tutti i nostri rimpianti, rimorsi e sensi di colpa, derivano da un’unica causa: l’ipertrofia dell’ego; quanto più essa è grande, tanto più grandi, e talvolta imperdonabili – ai nostri stessi occhi – sono gli errori, i rimpianti, i rimorsi e i sensi di colpa. Si soffre per una forma esagerata di attaccamento al proprio ego; e si provoca la sofferenza degli altri per la stessa ragione. Questa è la radice avvelenata del nostro soffrire e del nostro causare la sofferenza altrui. È l’ego a creare la voragine senza fondo, che, simile ad uno spaventoso “buco nero”, inghiotte e divora tutto quello che incontra; che rovina la bellezza e il profumo degli incontri che facciamo nella vita; che ci fa sprecare le occasioni di crescita; che ci ossessiona quando tali incontri e tali occasioni tornano a visitarci, nel ricordo, rimproverando amaramente la nostra coscienza.
In fondo, e una parte di noi lo sa molto bene, tutte le nostre sofferenze, tutti i nostri errori e tutti i nostri rimpianti, rimorsi e sensi di colpa, derivano da un’unica causa: l’ipertrofia dell’ego; quanto più essa è grande, tanto più grandi, e talvolta imperdonabili – ai nostri stessi occhi – sono gli errori, i rimpianti, i rimorsi e i sensi di colpa. Si soffre per una forma esagerata di attaccamento al proprio ego; e si provoca la sofferenza degli altri per la stessa ragione. Questa è la radice avvelenata del nostro soffrire e del nostro causare la sofferenza altrui. È l’ego a creare la voragine senza fondo, che, simile ad uno spaventoso “buco nero”, inghiotte e divora tutto quello che incontra; che rovina la bellezza e il profumo degli incontri che facciamo nella vita; che ci fa sprecare le occasioni di crescita; che ci ossessiona quando tali incontri e tali occasioni tornano a visitarci, nel ricordo, rimproverando amaramente la nostra coscienza.
Se riuscissimo a liberarci dall’idolatria dell’ego – che è anche, e soprattutto, una forma di schiavitù volontaria -, smetteremmo di soffrire in maniera sterile, e smetteremmo di far soffrire gli altri in maniera inutile e distruttiva. Non diciamo che smetteremmo di soffrire e di far soffrire in assoluto, perché questo non è dato agli esseri umani: la nostra natura di creature imperfette, anche se aspiranti alla perfezione, non ce lo consentirebbe. Però la nostra sofferenza, e quella che possiamo causare agli altri, verrebbe riscattata da un significato più alto: allora saremmo in grado di offrirla a Qualcuno che sa e che può, a Qualcuno che – Lui sì – è capace di trasformare anche il male in bene, senza limite alcuno.
Noi, questo, non lo possiamo fare; non da soli. Però sarebbe già molto se riuscissimo a dare un senso alla sofferenza, smettendo di provocarla – in noi e negli altri – a causa dell’attaccamento all’ego. Questo la purificherebbe, la trasporterebbe in regioni più respirabili. E sarebbe già molto…

 Articolo Precedente
Articolo Precedente Articolo Successivo
Articolo Successivo Il bunker: la follia di gente che non si “affida”
Il bunker: la follia di gente che non si “affida”  Grecia: e adesso sono cavoli amari
Grecia: e adesso sono cavoli amari  Campagne Glbt ed equivoci sul concetto di “odio”
Campagne Glbt ed equivoci sul concetto di “odio”  La “Festa della Liberazione”: un equivoco che nasce da un’errata concezione della libertà
La “Festa della Liberazione”: un equivoco che nasce da un’errata concezione della libertà  Magdi Allam alla riscossa!
Magdi Allam alla riscossa!  Nuovi ‘progressi’ per i palestinesi: dalla Cis-Giordania al Trans-gender!
Nuovi ‘progressi’ per i palestinesi: dalla Cis-Giordania al Trans-gender!  Dei musei e dell’aura delle opere
Dei musei e dell’aura delle opere  “Pellegrinaggi” significativi del ceto politico a casa di un “ribelle”
“Pellegrinaggi” significativi del ceto politico a casa di un “ribelle”