Quel continente di rifiuti in plastica alla deriva nelle acque del Pacifico
di Francesco Lamendola
 Possiamo immaginare un relitto che se ne vada alla deriva, smarrito nelle vastità dei mari; possiamo anche immaginare il relitto di una petroliera, che se ne vada disperdendo intorno a sé, purtroppo, una lunga, disastrosa scia di carburante, inquinando le acque in maniera drammatica e tale che ci vorranno degli anni, forse dei decenni, perché la natura riesca a “riassorbire”, almeno parzialmente, il danno ecologico così provocato. Oppure possiamo arrivare ad immaginare, nelle nostre fantasie più cupe, simili a degli incubi, una grande massa di rifiuti d’ogni genere, di carta, di legno, di vetro, di plastica, trascinate in mare dai fiumi e disperse qua e là dalle correnti: e sappiamo che i tempi di degrado biologico saranno molto diversi per i differenti materiali; sappiamo che la plastica sarà la più lenta e la più difficile da “smaltire”; e tuttavia, conoscendo l’immensità della superficie marina, che ricopre quasi i tre quarti dell’intera superficie del nostro pianeta, ci sembra impossibile, intuitivamente, che le cose, magari nel giro di parecchio tempo, non finiscano per sistemarsi, in una maniera o nell’altra; e che tutti quei rifiuti, insomma, non si disperdano, e in parte vadano a fondo, in parte si decompongano, e tutto finisca bene – prima o poi.
Possiamo immaginare un relitto che se ne vada alla deriva, smarrito nelle vastità dei mari; possiamo anche immaginare il relitto di una petroliera, che se ne vada disperdendo intorno a sé, purtroppo, una lunga, disastrosa scia di carburante, inquinando le acque in maniera drammatica e tale che ci vorranno degli anni, forse dei decenni, perché la natura riesca a “riassorbire”, almeno parzialmente, il danno ecologico così provocato. Oppure possiamo arrivare ad immaginare, nelle nostre fantasie più cupe, simili a degli incubi, una grande massa di rifiuti d’ogni genere, di carta, di legno, di vetro, di plastica, trascinate in mare dai fiumi e disperse qua e là dalle correnti: e sappiamo che i tempi di degrado biologico saranno molto diversi per i differenti materiali; sappiamo che la plastica sarà la più lenta e la più difficile da “smaltire”; e tuttavia, conoscendo l’immensità della superficie marina, che ricopre quasi i tre quarti dell’intera superficie del nostro pianeta, ci sembra impossibile, intuitivamente, che le cose, magari nel giro di parecchio tempo, non finiscano per sistemarsi, in una maniera o nell’altra; e che tutti quei rifiuti, insomma, non si disperdano, e in parte vadano a fondo, in parte si decompongano, e tutto finisca bene – prima o poi.
Siamo così abituati a pensare che l’uomo sia una entità relativamente piccola, e che il pianeta Terra sia sufficientemente grande per riequilibrare la sua mancanza di saggezza e previdenza, che non ci è naturale pensare che le ferite inferte all’ambiente da uno sviluppo industriale e tecnologico irresponsabile possano infine, sommandosi le une alle altre, diventare un problema senza soluzione; ci riesce innaturale pensare che l’inquinamento del mare, ad esempio, possa raggiungere un punto di non ritorno. Possiamo anche dire che ci è comodo pensare così; ci alleggerisce dal senso di colpa e anche dal peso di una eccessiva responsabilità che ci graverebbe sulle spalle, se tenessimo presente che il potere che l’uomo può esercitare sulla natura è, sì, sostanzialmente effimero, giudicato sulla scala geologica, ma terribilmente distruttivo, invece, se considerato sulla scala che a noi interessa nell’immediato: la scala storica e, almeno in parte (ossia per le conseguenze che lasceremo in eredità ai nostri figli e nipoti), quella biologica.
È comodo, ma non corrisponde a verità: si tratta di un falso pensiero. La verità è che noi siamo in grado, e lo stiamo facendo, di provocare danni ecologici irreversibili – quanto meno, appunto, sulla scala storica, quella di una, due o tre generazioni umane, e biologica, quella che copre alcune migliaia, o decine di migliaia, d’anni: si pensi, tanto per fare un esempio, che le scorie di una centrale nucleare restano radioattive, e dunque altamente contaminanti, per qualcosa come 20.000 anni. Da questi numeri emergono, impietosamente, tutta la nostra irresponsabilità e tutta la nostra mancanza di lungimiranza: in pratica, ci stiamo comportando come se non sapessimo che la Rivoluzione industriale ha moltiplicato per cento, per mille e per diecimila gli effetti a breve, medio e lungo termine che l’antropizzazione produce sull’ambiente, sull’atmosfera e sull’insieme del sistema biologico rappresentato dal nostro pianeta.
Per fare un altro esempio: basta prendere l’atlante sul quale abbiamo studiato pochi decenni fa, e confrontarlo con un atlante pubblicato ai nostri giorni: si vedrà, a occhio nudo, che il Mare d’Aral è più che dimezzato, o che il Lago Ciad si è ridotto a un paio di stagni, a fatica rintracciabili sulla carta dell’Africa centro-occidentale. Oppure si possono confrontare le fotografie degli anni ’60 e quelle odierne, relative ai ghiacciai delle Alpi (e anche di altre parti del mondo, come l’Himalaya o le Ande patagoniche): si vedrà immediatamente una grande differenza. I ghiacci si sono ritirati ovunque, in certi casi di decine di metri; montagne innevate non conoscono più la neve; perfino le banchise polari si vanno sciogliendo. Un solo dato: il ghiaccio dell’Aletsch, il gigante delle Alpi svizzere, si è ritirato di oltre 2.700 metri e continua ad “accorciarsi”: se questo è accaduto, e sta accadendo, al re dei ghiacciai dell’Europa, è facile immaginare cosa stia accadendo a quelli minori; i più piccoli stanno addirittura per scomparire. La superficie ghiacciata alla sommità del Kilimangiaro, nell’Africa orientale, si è ritirata del 75% (addio alle «nevi del Kilimangiaro», dunque, per dirla con Ernest Hemingway); il monte Carstensz, nella Nuova Guinea – ora denominato Puncak Jaya -, che è la vetta più alta di tutta l’Oceania, ha visto i suoi ghiacci ritirarsi di parecchie decine di metri solo negli ultimi quattro decenni (il ghiacciaio Meren, nella stessa catena, di ben duecento metri). E si potrebbe continuare a lungo.
E adesso, tornando alle nostre fantasie più cupe, dalle quali eravamo partiti per svolgere la presente riflessione, sappiamo che la realtà è diventata più terribile dei nostri peggiori incubi: oggi sappiamo che le correnti dell’Oceano Pacifico stanno portando alla deriva, avanti e indietro, con moto incessante, non una certa quantità di rifiuti, bensì una massa enorme di plastica, così vasta da poter essere definita come un’isola, anzi, come una specie di micro-continente galleggiante: il continente della vergogna.
Ha scritto Cristina Rutigliano a questo proposito (in: Gianni e Francesca Sofri, «Ambienti, popoli, idee. Conoscere il mondo», Bologna, Zanichelli, 2010, p. 108):
«IL VORTICE DEI RIFIUTI
Nell’ampia distesa dell’Oceano pacifico settentrionale, la circolazione generale dell’atmosfera influisce sui moti marini e in particolare, l’anticiclone subtropicale contribuisce alla formazione del cosiddetto “North Pacific Gyre” (vortice subtropicale dell’Oceano Pacifico), un immenso vortice esteso per circa 34 milioni di kmq. Le correnti girano in senso orario, rallentando man mano che si avvicinano al centro del vortice dove la turbolenza è praticamente assente. Quest’area è un deserto oceanico, affollato di fitoplancton, ma caratterizzato dall’assenza di pesci di grandi dimensioni e di mammiferi. Per questo motivo e a causa delle forti correnti, questa zona viene esclusa dalle comuni rotte di navigazione e raramente qualche peschereccio vi si avventura. Ma qui non c’è solo plancton. In quest’area, nel corso dei decenni, è rimasta intrappolata una quantità di rifiuti, per la maggior parte di plastica, pari a circa 35 milioni di tonnellate. È la più grande discarica presente sul nostro pianeta e galleggia nel mezzo dell’oceano. Nei periodi di calma atmosferica, i rifiuti si aggregano a formare delle vere e proprie isole di plastica. La più grande di queste, denominata The Eastern Garbage Patch, galleggia tra la California e le Hawaii e si distribuisce su una superficie ampia due volte lo stato del Texas o, per restare entro i nostri confini, circa 17 volte quella dell’Italia. Un altro sito di accumulo dei rifiuti, The Western Garbage Patch, si trova a ovest del Giappone [evidentemente un errore per “est” del Giappone] ed è dovuto alla circolazione antioraria del “North Pacific Gyre” orientale.
 Ma da dove arrivano questi rifiuti? La maggior parte proviene dalla terraferma e arriva in mare attraverso i fiumi, il resto è frutto degli scarichi delle petroliere e delle altre navi e infine degli scarichi abusivi.
Ma da dove arrivano questi rifiuti? La maggior parte proviene dalla terraferma e arriva in mare attraverso i fiumi, il resto è frutto degli scarichi delle petroliere e delle altre navi e infine degli scarichi abusivi.
Queste isole di plastica hanno degli effetti devastanti sugli ecosistemi, in modo particolare quelli marini. Mentre i rifiuti di origine biologica sono biodegradabili, la plastica si foto degrada, vale a dire che la luce solare la scinde in polimeri più piccoli altamente tossici (per esempio il polietilene), che si mescolano al plancton e vengono ingeriti da tutti gli animali che se ne nutrono, come per esempio le meduse. Questi animali sono alla base della catena alimentare e attraverso di essi la plastica viene ingerita da tutti gli animali che se ne cibano provocando così la morte per avvelenamento di tartarughe (100.000 vittime stimate), uccelli (oltre 1 milione di vittime) e mammiferi marini (100.000 vittime). Purtroppo, anche nel Mar Mediterraneo sono presenti due “strisce” di plastica, fortunatamente di dimensioni molto più piccole di quelle dell’Oceano pacifico, una tra Cagliari e le isole Egadi, l’altra tra La Spezia e l’Arcipelago Toscano.
Di tutta la plastica prodotta nel mondo, il 10% finisce negli oceani, dove costituisce il 90% dei rifiuti galleggianti; è stato calcolato che in alcune zone la quantità di plastica presente nell’acqua marina supera di sei volte quella del plancton, l’alimento base di moltissimi organismi che popolano gli oceani. Con tutte le conseguenze facilmente immaginabili…»
Ora, si tenga presente che i tempi di degradazione naturale dei materiali di rifiuto, in acqua, sono, in media, i seguenti: una buccia di banana 2 anni; un mozzicone di sigaretta, da 2 a 5 anni; una gomma da masticare, 5 anni; un accendino, 200 anni; un contenitore di polistirolo e un pannolino usa e getta, da 100 a 1.000 anni; una lattina d’alluminio per bibite, o un tessuto sintetico, 500 anni; una scheda telefonica, una bottiglia o un sacchetto di plastica, 1.000 anni (fonte: «Eco-Enciclopedia», consultabile in rete). È facile dedurne che la vergognosa, orribile isola di plastica galleggiante sulle acque dell’Oceano Pacifico non sparirà da sola nell’arco di una vita umana, e neanche in quello di poche generazioni; è perfino difficile capire che tipo di interventi dovrebbe fare l’uomo per rimediare al disastro da lui stesso provocato. Si tratta di uno di quei casi in cui l’irresponsabilità del nostro modello di sviluppo ha creato un problema talmente grande, che ci mancano quasi le categorie mentali non solo per provare ad affrontarlo, ma anche solo per riuscire a vederlo con chiarezza, in tutta la sua reale portata e in tutte le sue possibili conseguenze. È come se la nostra mente si rifiutasse di capire: perché capire significa anche accettare la realtà di quello che è accaduto, e, inevitabilmente, assumerne la responsabilità.
 Ma l’uomo contemporaneo, l’«homo tecnologicus», fiero e gonfio d’orgoglio per le sue scoperte e per la sua abilità nel manipolare le cose, è lontanissimo da un simile atteggiamento mentale; non gli passa neanche per l’anticamera del cervello di fare un doveroso “mea culpa”; è tutto proteso verso nuovi traguardi, e stavolta non limitati al dominio sull’ambiente, con la sua lunga scia di prodotti di rifiuto del processo industriale (il che implicherebbe un ripensamento della chimica, e specialmente del combustibile liquido quale principale fonte energetica per i trasporti), ma al dominio sulla materia vivente, dalla clonazione alla manipolazione genetica. Tutto preso dalle sue pratiche diaboliche di manipolazione del DNA, compreso quello umano, che cosa gli potrà mai importare di un dettaglio così banale, come un continente di plastica che se ne va alla deriva sulle acque del Pacifico? L’Oceano Pacifico è grande, egli immagina, nella sua crassa ignoranza e nel suo immenso infantilismo: ci penserà il mare a smaltire quei rifiuti, un poco alla volta.
Ma l’uomo contemporaneo, l’«homo tecnologicus», fiero e gonfio d’orgoglio per le sue scoperte e per la sua abilità nel manipolare le cose, è lontanissimo da un simile atteggiamento mentale; non gli passa neanche per l’anticamera del cervello di fare un doveroso “mea culpa”; è tutto proteso verso nuovi traguardi, e stavolta non limitati al dominio sull’ambiente, con la sua lunga scia di prodotti di rifiuto del processo industriale (il che implicherebbe un ripensamento della chimica, e specialmente del combustibile liquido quale principale fonte energetica per i trasporti), ma al dominio sulla materia vivente, dalla clonazione alla manipolazione genetica. Tutto preso dalle sue pratiche diaboliche di manipolazione del DNA, compreso quello umano, che cosa gli potrà mai importare di un dettaglio così banale, come un continente di plastica che se ne va alla deriva sulle acque del Pacifico? L’Oceano Pacifico è grande, egli immagina, nella sua crassa ignoranza e nel suo immenso infantilismo: ci penserà il mare a smaltire quei rifiuti, un poco alla volta.
E intanto il problema resta, anzi, cresce di giorno in giorno: ogni giorno, infatti, i fiumi portano nel mare una quantità imprecisata, ma comunque ragguardevole, di nuovi rifiuti, molti dei quali sono di plastica. Non vi è stato alcun ripensamento: di conseguenza, non è affatto cambiato il nostro modo di produrre, né il nostro modo di consumare; ci sembra perfettamente logico continuare a servirci di un materiale chimico che ci ha offerto tante comodità, ad un prezzo così modesto, quasi irrisorio: la plastica, appunto. Sarebbe da pazzi – si pensa – buttare via una simile risorsa, solo per mettere a tacere qualche vago scrupolo di natura ecologica. Infine, i nostri figli e i nostri nipoti sapranno certamente mettere a punto una tecnologia ancora più sofisticata della nostra, capace di risolvere qualunque problema, ecologico e non, scaturito dal modello di sviluppo consumista.
Ahimè, il punto è proprio questo: che non abbiamo il diritto di ipotecare il futuro delle prossime generazioni. E che finiremo per provocare un completo corto circuito fra la produzione di beni e la creazione di rifiuti difficili da smaltire, se non avremo il coraggio di rimettere in discussione, non la nostra tecnologia, ma il nostro modo di pensare e il nostro atteggiamento di fondo nei confronti di noi stessi e del fenomeno “vita”. La tecnologia, infatti, non è il problema, ma l’espressione materiale dei valori complessivi sui quali una civiltà si fonda; e, in se stessa, non è né buona, né cattiva. Diventa cattiva, anzi, pessima, se viene posta al servizio di un’idea faustiana e prometeica della presenza umana sul pianeta Terra; se viene adibita a servire la corsa pazza, sfrenata dell’Ego, che vuole e brama sempre di più, e intanto distrugge ogni cosa al suo passaggio.
Noi abbiamo bisogno di meno Ego e di più saggezza, di più umanità. Stiamo diventando disumani, perché ci siamo lasciati dominare dall’Ego: un signore dispotico, che vuole disporre di sempre più cose, anche se non ne ha realmente bisogno. La proliferazione di oggetti inutili e dannosi, a cominciare dai rifiuti industriali, nasce da qui. Abbiamo bisogno, pertanto, di riscoprire il valore della sobrietà, del silenzio e della contemplazione, se vogliamo smaltire l’ubriacatura dell’Ego…
Fonte: “Il Corriere delle Regioni”, 2 giu. 2015 (per gentile concessione dell’Autore)

 Articolo Precedente
Articolo Precedente Articolo Successivo
Articolo Successivo Occhio alle “bufale”: sì, ma a quelle del sistema!
Occhio alle “bufale”: sì, ma a quelle del sistema!  La via dell’inferno è lastricata di… “proteste”
La via dell’inferno è lastricata di… “proteste”  Quando il Progresso è un “bacio in pubblico” è davvero un brutto segno
Quando il Progresso è un “bacio in pubblico” è davvero un brutto segno  “Siti e poltrone”: l’attualità dei libri-inchiesta di Antonino Trizzino
“Siti e poltrone”: l’attualità dei libri-inchiesta di Antonino Trizzino  Non è giusto morire così
Non è giusto morire così  L’Europa ha un nemico: gli Stati Uniti d’America
L’Europa ha un nemico: gli Stati Uniti d’America 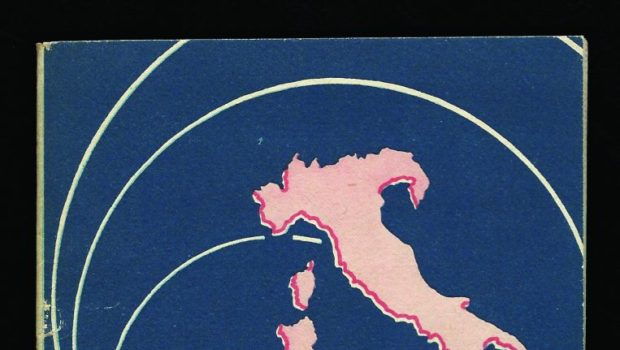 Se comandassi io…
Se comandassi io…  Siria e Corea nel mirino di Washington: l’“Asse del Male” non era solo propaganda
Siria e Corea nel mirino di Washington: l’“Asse del Male” non era solo propaganda